Proposta di lettura :Contro le donne Paolo Ercolani (libro) #liberopensiero2019
Contro le donne
Di Paolo Ercolani - Luglio 2016
Da: Contro le donne. Storia e critica del più antico pregiudizio di Paolo Ercolani, Marsilio, 2016
Introduzione: il più antico pregiudizio
 «La donna è una religione […] poesia vivente per sollevare l’uomo, crescere il bambino, nobilitare la famiglia» (Michelet 1860: 117)
«La donna è una religione […] poesia vivente per sollevare l’uomo, crescere il bambino, nobilitare la famiglia» (Michelet 1860: 117)
«Io me ne vado, amiche mie: perduta la gioia della vita, non desidero che morire.
Colui, da cui per me ogni retto giudizio dipendeva, si è rivelato il peggiore degli uomini: lo sposo mio.
Colui, da cui per me ogni retto giudizio dipendeva, si è rivelato il peggiore degli uomini: lo sposo mio.
Ma il fatto è questo: noi donne, fra tutti gli esseri animati e dotati di senno, siamo certo le creature più misere». (Euripide, Medea: vv. 225-231)
C’è una storia antica quanto il mondo umano, che nessuno ha mai raccontato.
Perlomeno non in maniera sistematica e critica, ossia cercando gli strumenti concettuali (e pratici) adatti per provare a superarla e lasciarsela alle spalle, come si dovrebbe fare con una vergogna che ci è appartenuta per troppo tempo.
Questa storia riguarda il pregiudizio contro le donne
Isteriche, instabili, irrazionali, inaffidabili, emotive, foriere dei mali e delle disgrazie peggiori. Anti-sociali, ferine. Puttane!
Lo scrittore Samuel Butler sosteneva che «gli uomini saggi non dicono mai ciò che pensano delle donne» (Woolf 1929: 37), ma evidentemente o si sbagliava oppure la storia ci ha rivelato una sorprendente penuria di uomini saggi.
Infatti, la lista secolare del pregiudizio misogino è lunga e sembra scritta sulla parete senza tempo dell’umanità.
Al punto che si rivela un’impresa improba, quella di provare ad elencare tutti gli aggettivi con cui gli autori uomini hanno voluto sottolinearela disgrazia e l’inferiorità rappresentate dall’essere femminile.
Eh sì, perché naturalmente si è trattato di un’operazione messa in piedi e condotta per secoli esclusivamente dagli uomini, che praticamente hanno parlato «fra di loro» della donna.
Insomma si è trattato un «dibattito tra uomini», per riprendere le considerazioni ironiche di Luce Irigaray (in un’opera che le costò l’allontanamento dall’Università, nel 1974!), dibattito che non doveva interessare né riguardare la donna, «di cui al limite ella non doveva sapere nulla» (Irigaray 1974: 9).
Un gran discutere fra uomini per arrivare a stabilire l’inferiorità inemendabile e irrecuperabile dell’essere femminile, tanto da giustificare e anzi rendere scontata, opportuna e persino necessaria la sottomissione al maschio.
Quest’ultimo, ovviamente, stabile, coerente, affidabile, razionale!
In una parola: superiore.
Quello contro la donna, a conti fatti, appare come il più antico, radicato e diffuso pregiudizio che la vicenda umana è stata in grado di produrre.
Un pregiudizio su cui ha messo il suo timbro non un signore qualunque, ma proprio il Signore in persona. Dio!
Basti pensare, per fare solo uno dei tanti esempi possibili, al suo comandamento di «non desiderare la donna d’altri».
Ebbene questo non si riferiva a una questione di lussuria, peraltro già affrontata in un comandamento precedente. Bensì, dando per scontato che la donna era merce di scambio e doveva essere relegata a mansioni di mera utilità nei confronti dell’uomo, invitava quest’ultimo a non desiderare praticamente la «serva» altrui (Wray 1999).
Perlomeno non in maniera sistematica e critica, ossia cercando gli strumenti concettuali (e pratici) adatti per provare a superarla e lasciarsela alle spalle, come si dovrebbe fare con una vergogna che ci è appartenuta per troppo tempo.
Questa storia riguarda il pregiudizio contro le donne
Isteriche, instabili, irrazionali, inaffidabili, emotive, foriere dei mali e delle disgrazie peggiori. Anti-sociali, ferine. Puttane!
Lo scrittore Samuel Butler sosteneva che «gli uomini saggi non dicono mai ciò che pensano delle donne» (Woolf 1929: 37), ma evidentemente o si sbagliava oppure la storia ci ha rivelato una sorprendente penuria di uomini saggi.
Infatti, la lista secolare del pregiudizio misogino è lunga e sembra scritta sulla parete senza tempo dell’umanità.
Al punto che si rivela un’impresa improba, quella di provare ad elencare tutti gli aggettivi con cui gli autori uomini hanno voluto sottolinearela disgrazia e l’inferiorità rappresentate dall’essere femminile.
Eh sì, perché naturalmente si è trattato di un’operazione messa in piedi e condotta per secoli esclusivamente dagli uomini, che praticamente hanno parlato «fra di loro» della donna.
Insomma si è trattato un «dibattito tra uomini», per riprendere le considerazioni ironiche di Luce Irigaray (in un’opera che le costò l’allontanamento dall’Università, nel 1974!), dibattito che non doveva interessare né riguardare la donna, «di cui al limite ella non doveva sapere nulla» (Irigaray 1974: 9).
Un gran discutere fra uomini per arrivare a stabilire l’inferiorità inemendabile e irrecuperabile dell’essere femminile, tanto da giustificare e anzi rendere scontata, opportuna e persino necessaria la sottomissione al maschio.
Quest’ultimo, ovviamente, stabile, coerente, affidabile, razionale!
In una parola: superiore.
Quello contro la donna, a conti fatti, appare come il più antico, radicato e diffuso pregiudizio che la vicenda umana è stata in grado di produrre.
Un pregiudizio su cui ha messo il suo timbro non un signore qualunque, ma proprio il Signore in persona. Dio!
Basti pensare, per fare solo uno dei tanti esempi possibili, al suo comandamento di «non desiderare la donna d’altri».
Ebbene questo non si riferiva a una questione di lussuria, peraltro già affrontata in un comandamento precedente. Bensì, dando per scontato che la donna era merce di scambio e doveva essere relegata a mansioni di mera utilità nei confronti dell’uomo, invitava quest’ultimo a non desiderare praticamente la «serva» altrui (Wray 1999).
1. Vino proibito, stupro consentito
All’originarietà del pregiudizio, aggiungiamo pure la sua inclinazione a radicarsi fin nelle più innocue abitudini della vita quotidiana.
Basti pensare a tutta l’ampia letteratura che, spaziando dal mondo greco a quello latino, testimoniava la convinzione diffusa per cui alle donne dovesse essere impedito gustare del vino, perché «sconveniente», pericoloso per la sua purezza, in grado di spingerla alla libidine più incontrollata (e quindi farla uscire, appunto, dal controllo esercitato su di lei dal maschio padrone).
Nella Roma antica, per ovviare a tutto ciò, esisteva il costume denominato ius osculi,che di fatto consentiva ai parenti di una fanciulla (fino al cugino di secondo grado) di baciarla sulla bocca in qualsiasi momento, per verificare che ella non avesse bevuto vino (e quindi che il suo alito non sapesse di temetum: bevanda inebriante).
Insomma, il controllo sulla purezza e la castità della donna era esercitato dalla stessa sfera dei parenti più stretti, che infatti rifiutavano a priori il bacio rituale a quelle dalla fama dubbia e chiacchierata (Euripide, Baccanti: vv. 260-2; Agostino, Confessiones: IX,8; Plinio il Giovane, Historia naturalis: v. III, 14, 90-2 e 140; Cicerone, De Republica: IV, 6, 6).
Del resto, ci troviamo di fronte a un fenomeno anch’esso molto antico. Da una parte la convinzione tutta maschile per cui la sessualità della donna è qualcosa di selvaggio e ingestibile, dall’altra la paura (anch’essa tutta maschile) di non riuscire più a esercitare il controllo assoluto su questa creatura tanto ferina, percepita come bisognosa di tutela da parte dell’uomo ma anche irrazionale e «diversa», imprevedibile. Quindi mai del tutto prona al controllo maschile, malgrado le apparenze.
Una convinzione radicata, questa, che l’uomo non ha mancato di portare alle estreme conseguenze, se è vero che già Christine de Pizan, nel 1400, denunciava con sdegno e dolore quel luogo comune maschile per cui la donna prova piacere nell’essere stuprata, presa con violenza malgrado le sue urla. Mentre la pittrice Artemisia Gentileschi compose appositamente un’opera (Giuditta che decapita Oloferne, 1612) per denunciare l’orribile atto di violenza e sopraffazione che l’uomo può compiere con lo stupro, stupro di cui la stessa pittrice era rimasta vittima l’anno prima.
Con Artemisia Gentileschi si era nel 1600, ma è significativo sapere che ancora nel 1993 l’americana Nancy Venables Raine riuscì a superare il trauma di uno stupro orribile («bendata e legata a un letto come un pollo»), raffigurando quel momento in un quadro intitolato Violentata e legata, che ella stessa si decise ad esporre in una mostra a Santa Cruz. Soltanto quella «oggettivazione» del terribile trauma le permise di recuperare una dignitosa sanità emotiva, avrebbe raccontato qualche anno dopo nel suo crudo ed angosciante memoriale della vicenda (de Pizan 1404-1405: 329; Valerio 2014: 90; Raine 1999).
Senza contare lo statuto di vero e proprio topos retorico assunto dallo stupro fin dall’antichità (che colpiva le donne ma anche i giovinetti), tanto che storici autorevoli come Erodoto e Tito Livio fanno risalire a questo atto di violenza nei confronti di alcune donne («ratto fondatore») nientemeno che la fondazione o la caduta di interi popoli, come è stato nel caso dei Romani, degli Ioni e dei Pelasgi. Mentre Aristotelelo racconta come un motivo ossessivamente ripetuto in quanto origine e causa di mutamenti costituzionali o caduta delle tirannidi (Erodoto, Storie: I, 146; VI, 137-8; Tito Livio, Storia di Roma: v. 1, I, 9; Aristotele, Politica: V, 10 1311b).
Non sono pochi gli uomini che ancora oggi coltivano nel profondo della propria anima la convinzione aberrante per cui la donna provi piacere nell’essere violentata. Tutto questo in virtù del fatto che quello fra uomo e donna viene inteso come un rapporto di potere, in cui la seconda è destinata a recitare il ruolo della preda e della vittima.
Del resto, è sufficiente leggere le parole del maestro per antonomasia dell’arte amatoria.
Stiamo parlando del poeta antico Ovidio, che nel dare consigli agli uomini scriveva che «la donna pur combattendo vuole essere vinta» (pugnando vinci se tamen illa volet), che «anche quando potresti credere che ella non voglia, poi cede».
Oppure, per sgombrare il campo dai dubbi sul fatto che il poeta potesse riferirsi soltanto a certi giochi amorosi, in cui il maschio e la femmina decidono liberamente di recitare il ruolo del cacciatore e della preda per puro piacere, si possono leggere quei passi in cui scriveva che «la violenza è gradita alle fanciulle» (grata est vis puellis), poiché «quello che a loro piace, spesso vogliono darlo contro la loro volontà» (quod iuvat, invitae saepe dedisse volunt), (Ovidio, Ars amatoria: v. 1, I, 674; I, 274 e I, 671-2).
Nel frattempo sono passati due millenni, ma ancora alla metà del 1900 il medico e psicoanalista Alexander Lowen poteva constatare la vera e propria «doppia norma morale» che differenzia la condizione dell’uomo e della donna rispetto alla sessualità. Da ammirare il primo nella sua veste di seduttore, da compatire la seconda in quanto sedotta e perciò battuta.
Ella, nella sua veste di «oggetto sessuale» si rivela come un «essere inferiore» (da compatire o, nella peggiore delle ipotesi, stuprare liberamente), mentre è come madre devota e che si sacrifica che può aspirare a un’immagine di superiorità (Lowen 1965: 255).
Ovviamente questi radicati pregiudizi culturali non si sono limitati ad esercitare un’influenza sul piano esclusivamente teorico.
Sondaggi condotti fra il 1965 e il 1972, infatti, rivelavano che quasi il 60 per cento delle donne aveva paura di girare da sola la sera, mentre ancora agli inizi degli anni Novanta del Novecento quasi il 70 per cento delle donne credeva che «uomini di ogni tipo, molti dei quali per altri versi si rivelano normali e rispettabili, sono degli stupratori».
Né, evidentemente, si tratta soltanto di una paura che le donne coltivano nel loro animo, in seguito alla consapevolezza del pregiudizio maschile che le vorrebbe naturalmente predisposte (e persino compiaciute) ad essere oggetto di violenza e di stupro.
Un sondaggio del governo americano sullo stupro e sulle violenze domestiche, infatti, rivelava alla fine del 2011 che almeno una donna americana su cinque ne era rimasta vittima. La percentuale non cambia se ci spostiamo nel continente europeo, secondo un sondaggio condotto dall’Agenzia per i diritti fondamentali che si riferisce al 2015.
Sempre nel 2015, un sondaggio commissionato dall’Associazione delle Università americane, portava alla luce il fatto che più di una studentessa su quattro è rimasta vittima di aggressioni sessuali all’interno di un ambiente ricercato e, tutto sommato, protetto quale è o dovrebbe essere il Campus universitario.
A tutti questi dati possiamo aggiungere la vera e propria «teologia dello stupro» messa in atto ai giorni nostri dai combattenti dello Stato islamico (autori di violenze sessuali nei confronti di ragazze e bambine non appartenenti all’Islam), oppure il mercato di «schiave del sesso» particolarmente florido negli ex paesi comunisti ma diffuso in tutto il mondo ormai monopolizzato dall’«economia canaglia».
Dopodiché non può destare alcuna meraviglia il dato diffuso dall’ONU (2013) secondo cui più di una donna su tre (il 35%), nel mondo, è rimasta vittima di violenze fisiche e/o sessuali da parte del partner o di estranei (Erskine 1974: 131; Weiser Eastell 1993: 23; Caryn Rabin 2011: A32; Peyret e BIG 2015; Pérez-Peña 2015: A17; Callimachi 2015: A1; Napoleoni 2008: 10-30).
Da tutto ciò risulta con drammatica evidenza che combattere il più antico pregiudizio della storia umana significa, in qualche modo, impegnarsi anche per debellare la secolare vergogna della violenza psicologica, fisica e sessuale contro le donne.
Mai come in questo caso, forse, emerge il nesso radicale che rende confinanti il territorio delle idee con quello della traduzione in pratica delle stesse.
Basti pensare a tutta l’ampia letteratura che, spaziando dal mondo greco a quello latino, testimoniava la convinzione diffusa per cui alle donne dovesse essere impedito gustare del vino, perché «sconveniente», pericoloso per la sua purezza, in grado di spingerla alla libidine più incontrollata (e quindi farla uscire, appunto, dal controllo esercitato su di lei dal maschio padrone).
Nella Roma antica, per ovviare a tutto ciò, esisteva il costume denominato ius osculi,che di fatto consentiva ai parenti di una fanciulla (fino al cugino di secondo grado) di baciarla sulla bocca in qualsiasi momento, per verificare che ella non avesse bevuto vino (e quindi che il suo alito non sapesse di temetum: bevanda inebriante).
Insomma, il controllo sulla purezza e la castità della donna era esercitato dalla stessa sfera dei parenti più stretti, che infatti rifiutavano a priori il bacio rituale a quelle dalla fama dubbia e chiacchierata (Euripide, Baccanti: vv. 260-2; Agostino, Confessiones: IX,8; Plinio il Giovane, Historia naturalis: v. III, 14, 90-2 e 140; Cicerone, De Republica: IV, 6, 6).
Del resto, ci troviamo di fronte a un fenomeno anch’esso molto antico. Da una parte la convinzione tutta maschile per cui la sessualità della donna è qualcosa di selvaggio e ingestibile, dall’altra la paura (anch’essa tutta maschile) di non riuscire più a esercitare il controllo assoluto su questa creatura tanto ferina, percepita come bisognosa di tutela da parte dell’uomo ma anche irrazionale e «diversa», imprevedibile. Quindi mai del tutto prona al controllo maschile, malgrado le apparenze.
Una convinzione radicata, questa, che l’uomo non ha mancato di portare alle estreme conseguenze, se è vero che già Christine de Pizan, nel 1400, denunciava con sdegno e dolore quel luogo comune maschile per cui la donna prova piacere nell’essere stuprata, presa con violenza malgrado le sue urla. Mentre la pittrice Artemisia Gentileschi compose appositamente un’opera (Giuditta che decapita Oloferne, 1612) per denunciare l’orribile atto di violenza e sopraffazione che l’uomo può compiere con lo stupro, stupro di cui la stessa pittrice era rimasta vittima l’anno prima.
Con Artemisia Gentileschi si era nel 1600, ma è significativo sapere che ancora nel 1993 l’americana Nancy Venables Raine riuscì a superare il trauma di uno stupro orribile («bendata e legata a un letto come un pollo»), raffigurando quel momento in un quadro intitolato Violentata e legata, che ella stessa si decise ad esporre in una mostra a Santa Cruz. Soltanto quella «oggettivazione» del terribile trauma le permise di recuperare una dignitosa sanità emotiva, avrebbe raccontato qualche anno dopo nel suo crudo ed angosciante memoriale della vicenda (de Pizan 1404-1405: 329; Valerio 2014: 90; Raine 1999).
Senza contare lo statuto di vero e proprio topos retorico assunto dallo stupro fin dall’antichità (che colpiva le donne ma anche i giovinetti), tanto che storici autorevoli come Erodoto e Tito Livio fanno risalire a questo atto di violenza nei confronti di alcune donne («ratto fondatore») nientemeno che la fondazione o la caduta di interi popoli, come è stato nel caso dei Romani, degli Ioni e dei Pelasgi. Mentre Aristotelelo racconta come un motivo ossessivamente ripetuto in quanto origine e causa di mutamenti costituzionali o caduta delle tirannidi (Erodoto, Storie: I, 146; VI, 137-8; Tito Livio, Storia di Roma: v. 1, I, 9; Aristotele, Politica: V, 10 1311b).
Non sono pochi gli uomini che ancora oggi coltivano nel profondo della propria anima la convinzione aberrante per cui la donna provi piacere nell’essere violentata. Tutto questo in virtù del fatto che quello fra uomo e donna viene inteso come un rapporto di potere, in cui la seconda è destinata a recitare il ruolo della preda e della vittima.
Del resto, è sufficiente leggere le parole del maestro per antonomasia dell’arte amatoria.
Stiamo parlando del poeta antico Ovidio, che nel dare consigli agli uomini scriveva che «la donna pur combattendo vuole essere vinta» (pugnando vinci se tamen illa volet), che «anche quando potresti credere che ella non voglia, poi cede».
Oppure, per sgombrare il campo dai dubbi sul fatto che il poeta potesse riferirsi soltanto a certi giochi amorosi, in cui il maschio e la femmina decidono liberamente di recitare il ruolo del cacciatore e della preda per puro piacere, si possono leggere quei passi in cui scriveva che «la violenza è gradita alle fanciulle» (grata est vis puellis), poiché «quello che a loro piace, spesso vogliono darlo contro la loro volontà» (quod iuvat, invitae saepe dedisse volunt), (Ovidio, Ars amatoria: v. 1, I, 674; I, 274 e I, 671-2).
Nel frattempo sono passati due millenni, ma ancora alla metà del 1900 il medico e psicoanalista Alexander Lowen poteva constatare la vera e propria «doppia norma morale» che differenzia la condizione dell’uomo e della donna rispetto alla sessualità. Da ammirare il primo nella sua veste di seduttore, da compatire la seconda in quanto sedotta e perciò battuta.
Ella, nella sua veste di «oggetto sessuale» si rivela come un «essere inferiore» (da compatire o, nella peggiore delle ipotesi, stuprare liberamente), mentre è come madre devota e che si sacrifica che può aspirare a un’immagine di superiorità (Lowen 1965: 255).
Ovviamente questi radicati pregiudizi culturali non si sono limitati ad esercitare un’influenza sul piano esclusivamente teorico.
Sondaggi condotti fra il 1965 e il 1972, infatti, rivelavano che quasi il 60 per cento delle donne aveva paura di girare da sola la sera, mentre ancora agli inizi degli anni Novanta del Novecento quasi il 70 per cento delle donne credeva che «uomini di ogni tipo, molti dei quali per altri versi si rivelano normali e rispettabili, sono degli stupratori».
Né, evidentemente, si tratta soltanto di una paura che le donne coltivano nel loro animo, in seguito alla consapevolezza del pregiudizio maschile che le vorrebbe naturalmente predisposte (e persino compiaciute) ad essere oggetto di violenza e di stupro.
Un sondaggio del governo americano sullo stupro e sulle violenze domestiche, infatti, rivelava alla fine del 2011 che almeno una donna americana su cinque ne era rimasta vittima. La percentuale non cambia se ci spostiamo nel continente europeo, secondo un sondaggio condotto dall’Agenzia per i diritti fondamentali che si riferisce al 2015.
Sempre nel 2015, un sondaggio commissionato dall’Associazione delle Università americane, portava alla luce il fatto che più di una studentessa su quattro è rimasta vittima di aggressioni sessuali all’interno di un ambiente ricercato e, tutto sommato, protetto quale è o dovrebbe essere il Campus universitario.
A tutti questi dati possiamo aggiungere la vera e propria «teologia dello stupro» messa in atto ai giorni nostri dai combattenti dello Stato islamico (autori di violenze sessuali nei confronti di ragazze e bambine non appartenenti all’Islam), oppure il mercato di «schiave del sesso» particolarmente florido negli ex paesi comunisti ma diffuso in tutto il mondo ormai monopolizzato dall’«economia canaglia».
Dopodiché non può destare alcuna meraviglia il dato diffuso dall’ONU (2013) secondo cui più di una donna su tre (il 35%), nel mondo, è rimasta vittima di violenze fisiche e/o sessuali da parte del partner o di estranei (Erskine 1974: 131; Weiser Eastell 1993: 23; Caryn Rabin 2011: A32; Peyret e BIG 2015; Pérez-Peña 2015: A17; Callimachi 2015: A1; Napoleoni 2008: 10-30).
Da tutto ciò risulta con drammatica evidenza che combattere il più antico pregiudizio della storia umana significa, in qualche modo, impegnarsi anche per debellare la secolare vergogna della violenza psicologica, fisica e sessuale contro le donne.
Mai come in questo caso, forse, emerge il nesso radicale che rende confinanti il territorio delle idee con quello della traduzione in pratica delle stesse.
2. Il velo di ignoranza
Il pregiudizio più antico e radicato, quindi, ma anche quello più in grado di superare le differenze etniche e culturali nonché le distanze geografiche.
Fin dall’antichità, infatti, in India anche le donne delle caste superiori erano equiparate ai gradi inferiori della società. Nell’Ellade dorica non le veniva riconosciuto praticamente alcun diritto per tutta la vita (vita che si svolgeva rigorosamente sotto la tutela, di volta in volta, del padre e poi del marito). Mentre a Roma, in virtù della sua natura ritenuta inferiore a quella maschile, veniva giuridicamente inquadrata come figlia di suo marito e sorella dei suoi stessi figli.
Ma proviamo a riflettere un momento, solo per citare un esempio, sul biasimo generalizzato che la nostra civiltà cristiana rivolge nei confronti dell’islam per la questione del velo, la forma più esteriore ed appariscente di discriminazione della donna in quella civiltà, anche se certamente non la più grave.
Ebbene, da questo punto di vista potrebbe generare una certa sorpresa venire a conoscenza del fatto che, in realtà, era nell’Atene democratica, tanto esaltata dalla tradizione occidentale, che si diffuse il costume di imporre alle donne il velo di fronte a situazioni pubbliche e a uomini scapoli, al contrario di quello che accadeva per coloro che a quel tempo vivevano in Persia o in Siria (Llewellyn – Jones 2003: 14).
Oppure, rivolgendo l’attenzione ai giorni nostri, possiamo constatare che nel caso delle donne la «globalizzazione» è tale innanzitutto per il pregiudizio che le colpisce, nonché per le discriminazioni e le imposizioni di cui esse sono vittime a livello planetario, a prescindere dal paese in questione e dalla cultura che lo caratterizza.
È il caso della Cina post-socialista, da più parti considerata la nazione destinata ad esercitare un’egemonia planetaria nell’arco di un breve futuro, ma a proposito della quale uno studio meticoloso parla di «ritorno della disuguaglianza di genere» in seguito alle riforme impresse dalla svolta capitalista.
E certamente solo di «ritorno» si può parlare, visto che due dei testi più autorevoli della cultura cinese antica si esprimevano in questi termini: «Quando una donna passa dalla casa paterna a quella dello sposo, perde tutto, perfino il nome. Essa non ha più nulla in proprio: ciò che essa porta, ciò che essa è, la sua persona, tutto appartiene a colui che le si dà come sposo». E comunque, anche all’interno dello stesso focolare domestico, ella deve comportarsi «come un’ombra e un semplice eco» (Fincher 2014; Evola 1958: 203-4).
Il pregiudizio più antico e diagonale rispetto alle varie culture, il più radicato ma anche quello maggiormente in grado di colpire uomini di ogni credo e livello.
Che fossero atei o credenti, pagani o cristiani, progressisti o conservatori, rivoluzionari o reazionari, tragediografi o scrittori, scienziati o pensatori, tutti i più grandi artefici della cultura occidentale (naturalmente maschi) si sono ritrovati e spalleggiati nella condanna e nella subordinazione dell’essere femminile.
Con una consonanza di argomentazioni e motivazioni da suscitare l’impressione più grande e incredula.
Sia sufficiente un esempio. Basta aprire le opere di Origene, teologo e filosofo greco a cavallo tra il II e il III secolo d.C., probabilmente il primo grande autore a sistematizzare la filosofia cristiana tenendo comunque in forte considerazione l’insegnamento e il lascito di quella pagana.
Ebbene, leggendo Origene si scopre che questi dava per scontata l’inferiorità della donna rispetto all’uomo, indicandola lungo tutta la sua opera come il polo negativo della creazione terrena: femminile è per lui sinonimo di debolezza, peccato e lascivia (laddove l’uomo rappresenta la forza, la virtù e la continenza). Oppure ancora: in caso di matrimonio egli prescrive la fedeltà a entrambi i coniugi, ma rifacendosi alla Bibbia ritiene che solo se a compiere adulterio è la donna allora la separazione si rivela inevitabile.
Infine: in merito alla generazione dei figli egli riconosce al seme paterno il ruolo determinante, mentre riduce la donna al ruolo di mero ricettacolo, che per questo rappresenta la parte indecente e impura della comparsa al mondo di ogni individuo(1).
Certo, Origene era un autore cristiano, ma sarebbe un errore credere che queste idee sulla donna fossero confinate al solo ambito del cristianesimo.
Esse, piuttosto, si rivelano perfettamente uniformi a quanto pensato e scritto, per esempio, da Pitagora e Aristotele, a conferma del fatto che il pregiudizio misogino è stato perfettamente in grado di riprodursi e perpetuarsi attraverso le correnti di pensiero più diverse fra loro.
Né si può pensare che quella contro le donne sia stata la prerogativa di un mondo antico, di un pensiero non ancora del tutto sviluppato.
A tal proposito è sufficiente prendere un autore come Diderot, che non solo scriveva nella seconda metà del Settecento (quindi mille e cinquecento anni dopo Origene), ma era anche un esponente di spicco di quel movimento illuminista che nella critica ai dogmi e alle superstizioni della religione avrebbe trovato la sua principale ragion d’essere.
Ebbene, anche Diderot quando si trattava di donne le descriveva come esseri che, mancanti di riflessione e di principi, si rivelano incapaci di un intendimento profondo e convinto. Superficiali nelle loro idee di giustizia, di virtù e di vizio, ma anche di bontà, malgrado le apparenze esteriori manifestano una natura interiore selvaggia e machiavellica.
Insomma, nell’uomo predomina la ragione tanto quanto nella donna è l’istinto a rivelarsi preminente, al punto che esse raramente si rivelano sistematiche ma piuttosto sempre alla mercé del momento (Diderot 1772: v. 2, 260-1).
Con una tradizione di pensiero così radicale e compatta alle spalle, che per di più ha potuto lavorare per secoli, non c’è da meravigliarsi che la donna fosse ritenuta inadeguata a ricoprire qualunque ruolo diverso da quello di occuparsi della casa e allevare figli.
Fin dall’antichità, infatti, in India anche le donne delle caste superiori erano equiparate ai gradi inferiori della società. Nell’Ellade dorica non le veniva riconosciuto praticamente alcun diritto per tutta la vita (vita che si svolgeva rigorosamente sotto la tutela, di volta in volta, del padre e poi del marito). Mentre a Roma, in virtù della sua natura ritenuta inferiore a quella maschile, veniva giuridicamente inquadrata come figlia di suo marito e sorella dei suoi stessi figli.
Ma proviamo a riflettere un momento, solo per citare un esempio, sul biasimo generalizzato che la nostra civiltà cristiana rivolge nei confronti dell’islam per la questione del velo, la forma più esteriore ed appariscente di discriminazione della donna in quella civiltà, anche se certamente non la più grave.
Ebbene, da questo punto di vista potrebbe generare una certa sorpresa venire a conoscenza del fatto che, in realtà, era nell’Atene democratica, tanto esaltata dalla tradizione occidentale, che si diffuse il costume di imporre alle donne il velo di fronte a situazioni pubbliche e a uomini scapoli, al contrario di quello che accadeva per coloro che a quel tempo vivevano in Persia o in Siria (Llewellyn – Jones 2003: 14).
Oppure, rivolgendo l’attenzione ai giorni nostri, possiamo constatare che nel caso delle donne la «globalizzazione» è tale innanzitutto per il pregiudizio che le colpisce, nonché per le discriminazioni e le imposizioni di cui esse sono vittime a livello planetario, a prescindere dal paese in questione e dalla cultura che lo caratterizza.
È il caso della Cina post-socialista, da più parti considerata la nazione destinata ad esercitare un’egemonia planetaria nell’arco di un breve futuro, ma a proposito della quale uno studio meticoloso parla di «ritorno della disuguaglianza di genere» in seguito alle riforme impresse dalla svolta capitalista.
E certamente solo di «ritorno» si può parlare, visto che due dei testi più autorevoli della cultura cinese antica si esprimevano in questi termini: «Quando una donna passa dalla casa paterna a quella dello sposo, perde tutto, perfino il nome. Essa non ha più nulla in proprio: ciò che essa porta, ciò che essa è, la sua persona, tutto appartiene a colui che le si dà come sposo». E comunque, anche all’interno dello stesso focolare domestico, ella deve comportarsi «come un’ombra e un semplice eco» (Fincher 2014; Evola 1958: 203-4).
Il pregiudizio più antico e diagonale rispetto alle varie culture, il più radicato ma anche quello maggiormente in grado di colpire uomini di ogni credo e livello.
Che fossero atei o credenti, pagani o cristiani, progressisti o conservatori, rivoluzionari o reazionari, tragediografi o scrittori, scienziati o pensatori, tutti i più grandi artefici della cultura occidentale (naturalmente maschi) si sono ritrovati e spalleggiati nella condanna e nella subordinazione dell’essere femminile.
Con una consonanza di argomentazioni e motivazioni da suscitare l’impressione più grande e incredula.
Sia sufficiente un esempio. Basta aprire le opere di Origene, teologo e filosofo greco a cavallo tra il II e il III secolo d.C., probabilmente il primo grande autore a sistematizzare la filosofia cristiana tenendo comunque in forte considerazione l’insegnamento e il lascito di quella pagana.
Ebbene, leggendo Origene si scopre che questi dava per scontata l’inferiorità della donna rispetto all’uomo, indicandola lungo tutta la sua opera come il polo negativo della creazione terrena: femminile è per lui sinonimo di debolezza, peccato e lascivia (laddove l’uomo rappresenta la forza, la virtù e la continenza). Oppure ancora: in caso di matrimonio egli prescrive la fedeltà a entrambi i coniugi, ma rifacendosi alla Bibbia ritiene che solo se a compiere adulterio è la donna allora la separazione si rivela inevitabile.
Infine: in merito alla generazione dei figli egli riconosce al seme paterno il ruolo determinante, mentre riduce la donna al ruolo di mero ricettacolo, che per questo rappresenta la parte indecente e impura della comparsa al mondo di ogni individuo(1).
Certo, Origene era un autore cristiano, ma sarebbe un errore credere che queste idee sulla donna fossero confinate al solo ambito del cristianesimo.
Esse, piuttosto, si rivelano perfettamente uniformi a quanto pensato e scritto, per esempio, da Pitagora e Aristotele, a conferma del fatto che il pregiudizio misogino è stato perfettamente in grado di riprodursi e perpetuarsi attraverso le correnti di pensiero più diverse fra loro.
Né si può pensare che quella contro le donne sia stata la prerogativa di un mondo antico, di un pensiero non ancora del tutto sviluppato.
A tal proposito è sufficiente prendere un autore come Diderot, che non solo scriveva nella seconda metà del Settecento (quindi mille e cinquecento anni dopo Origene), ma era anche un esponente di spicco di quel movimento illuminista che nella critica ai dogmi e alle superstizioni della religione avrebbe trovato la sua principale ragion d’essere.
Ebbene, anche Diderot quando si trattava di donne le descriveva come esseri che, mancanti di riflessione e di principi, si rivelano incapaci di un intendimento profondo e convinto. Superficiali nelle loro idee di giustizia, di virtù e di vizio, ma anche di bontà, malgrado le apparenze esteriori manifestano una natura interiore selvaggia e machiavellica.
Insomma, nell’uomo predomina la ragione tanto quanto nella donna è l’istinto a rivelarsi preminente, al punto che esse raramente si rivelano sistematiche ma piuttosto sempre alla mercé del momento (Diderot 1772: v. 2, 260-1).
Con una tradizione di pensiero così radicale e compatta alle spalle, che per di più ha potuto lavorare per secoli, non c’è da meravigliarsi che la donna fosse ritenuta inadeguata a ricoprire qualunque ruolo diverso da quello di occuparsi della casa e allevare figli.
3. Inferiore e ausiliare al maschio
Visti quei presupposti, piuttosto, la donna si è vista sbarrata per secoli ogni strada che potesse condurla a una qualsivoglia attività difforme dal ruolo predefinito di ausiliare (una costola) della creatura principale, del «primo sesso»: il maschio.
A questo proposito, come non ricordare le parole sofferte e profonde con cui Virginia Woolf descriveva la condizione miserevole che le donne di genio hanno dovuto subire lungo il corso della storia.
Sì, perché scrivere un’opera di genio si è rivelata già di per sé un’impresa titanica per ciascuno, fra mille difficoltà, pregiudizi, fatica nel cercare di garantirsi comunque il pane quotidiano. Ma il fatto è che, anche a giudicare dagli «scaffali vuoti» di opere composte da donne, per queste ultime la suddetta difficoltà si è rivelata infinitamente più formidabile e, alla fine, proibitiva.
Quell’indifferenza che il mondo ha spesso riservato a scrittori e poeti, facendo soffrire tremendamente autori del calibro di Keats e Flaubert, nel caso della donna diventava vera e propria ostilità. Il mondo non le diceva, come agli altri scrittori, «scrivi, scrivi pure, tanto a me cosa importa?!», quanto piuttosto «Scrivi?! E a cosa ti serve scrivere?!».
La Woolf sintetizzava con efficacia il tormento che poteva colpire una donna di questo tipo, laddove si chiedeva con retorica sofferta: «chi può misurare il fuoco interiore e la violenza del cuore di un poeta, quando esso si trova prigioniero e intrappolato nel corpo di una donna?» (Woolf 1929: 66-8 e 62).
Naturalmente, la forte discriminazione della donna in ambito lavorativo (che per molti secoli è stata vera e propria esclusione), non ha colpito soltanto coloro che avrebbero potuto aspirare alla carriera scientifica o letteraria, o in generale a occupazioni di natura intellettuale.
Basti pensare, infatti, che ancora ai giorni nostri studiosi dei flussi lavorativi parlano di una «divisione del lavoro sessuata», al punto che l’origine stessa del «lavoro flessibile» si rivela direttamente correlata alla femminizzazione della forza lavoro pagata.
In altre parole, insomma, sono le donne a sobbarcarsi in misura maggiore i lavori precari, poco garantiti e malpagati, tipici della nostra epoca da quarant’anni a questa parte, poiché «l’organizzazione patriarcale della famiglia le spinge a considerare l’organizzazione flessibile delle loro occupazioni professionali come l’unico modo per rendere compatibile famiglia e lavoro» (Castells 2009: 30; Carnoy 2000: 96-100).
Per il resto, anche nei rari casi in cui è capitato che qualche autore blandisse la donna, riconoscendone la grazia, la bellezza, o perfino la «superiorità», ciò è avvenuto col solo scopo di confermare, alla fine del ragionamento, che cotanta creatura rappresentava il miglior ausilio e conforto per le faticose imprese dell’uomo. Un rifugio dell’anima, insomma, e nulla più.
Tanto che ancora oggi, gli uomini che sono disposti a celebrare una presunta superiorità della donna, magari in quanto capace di donare la vita ed essere baluardo della famiglia, finiscono col confermare e perpetuare più o meno consapevolmente la forma più vile e ipocrita del pensiero misogino.
La forza di questo pregiudizio contro la donna è stata ed è tale che persino una parte del femminismo ha finito col cadere in un errore paradossalmente «misogino»: ossia profetizzare e lavorare per la costruzione di un soggetto umano asessuato, al di là delle categorie di maschile e femminile. Insomma, illudendosi di risolvere la secolare e vergognosa sottomissione della donna all’uomo tramite il superamento delle stesse identità sessuali, quindi tramite la negazione e l’annullamento di quella differenza e specificità femminile a cui invece, a nostro avviso, va finalmente riconosciuta piena dignità e possibilità di esprimere un valore «altro» e indispensabile alla completezza del genere umano.
Una «soluzione» post o anti umana, per una questione radicalmente umana quale è il pregiudizio e la prevaricazione del più forte sul più debole, non può rappresentare una via da percorrere per chiunque abbia a cuore le sorti dell’umanità.
Anche oggi che quasi nessuno ha più il coraggio (e il buon senso) di esplicitare quei pensieri sulle donne (e molto spesso sono le donne stesse a sminuirsi e mortificarsi rispetto al maschio, in una sorta di «autofobia» indotta da secoli di indottrinamento), bisogna sapere che il pregiudizio misogino esiste e lavora nell’oscurità dell’animo di ognuno di noi.
Il lavorio profondo e costante che esso ha esercitato lungo i secoli, infatti, ha finito col costruire un retroterra di convinzioni e distinguo che è assai arduo mettere in discussione. Figuriamoci estirparlo.
A questo proposito, come non ricordare le parole sofferte e profonde con cui Virginia Woolf descriveva la condizione miserevole che le donne di genio hanno dovuto subire lungo il corso della storia.
Sì, perché scrivere un’opera di genio si è rivelata già di per sé un’impresa titanica per ciascuno, fra mille difficoltà, pregiudizi, fatica nel cercare di garantirsi comunque il pane quotidiano. Ma il fatto è che, anche a giudicare dagli «scaffali vuoti» di opere composte da donne, per queste ultime la suddetta difficoltà si è rivelata infinitamente più formidabile e, alla fine, proibitiva.
Quell’indifferenza che il mondo ha spesso riservato a scrittori e poeti, facendo soffrire tremendamente autori del calibro di Keats e Flaubert, nel caso della donna diventava vera e propria ostilità. Il mondo non le diceva, come agli altri scrittori, «scrivi, scrivi pure, tanto a me cosa importa?!», quanto piuttosto «Scrivi?! E a cosa ti serve scrivere?!».
La Woolf sintetizzava con efficacia il tormento che poteva colpire una donna di questo tipo, laddove si chiedeva con retorica sofferta: «chi può misurare il fuoco interiore e la violenza del cuore di un poeta, quando esso si trova prigioniero e intrappolato nel corpo di una donna?» (Woolf 1929: 66-8 e 62).
Naturalmente, la forte discriminazione della donna in ambito lavorativo (che per molti secoli è stata vera e propria esclusione), non ha colpito soltanto coloro che avrebbero potuto aspirare alla carriera scientifica o letteraria, o in generale a occupazioni di natura intellettuale.
Basti pensare, infatti, che ancora ai giorni nostri studiosi dei flussi lavorativi parlano di una «divisione del lavoro sessuata», al punto che l’origine stessa del «lavoro flessibile» si rivela direttamente correlata alla femminizzazione della forza lavoro pagata.
In altre parole, insomma, sono le donne a sobbarcarsi in misura maggiore i lavori precari, poco garantiti e malpagati, tipici della nostra epoca da quarant’anni a questa parte, poiché «l’organizzazione patriarcale della famiglia le spinge a considerare l’organizzazione flessibile delle loro occupazioni professionali come l’unico modo per rendere compatibile famiglia e lavoro» (Castells 2009: 30; Carnoy 2000: 96-100).
Per il resto, anche nei rari casi in cui è capitato che qualche autore blandisse la donna, riconoscendone la grazia, la bellezza, o perfino la «superiorità», ciò è avvenuto col solo scopo di confermare, alla fine del ragionamento, che cotanta creatura rappresentava il miglior ausilio e conforto per le faticose imprese dell’uomo. Un rifugio dell’anima, insomma, e nulla più.
Tanto che ancora oggi, gli uomini che sono disposti a celebrare una presunta superiorità della donna, magari in quanto capace di donare la vita ed essere baluardo della famiglia, finiscono col confermare e perpetuare più o meno consapevolmente la forma più vile e ipocrita del pensiero misogino.
La forza di questo pregiudizio contro la donna è stata ed è tale che persino una parte del femminismo ha finito col cadere in un errore paradossalmente «misogino»: ossia profetizzare e lavorare per la costruzione di un soggetto umano asessuato, al di là delle categorie di maschile e femminile. Insomma, illudendosi di risolvere la secolare e vergognosa sottomissione della donna all’uomo tramite il superamento delle stesse identità sessuali, quindi tramite la negazione e l’annullamento di quella differenza e specificità femminile a cui invece, a nostro avviso, va finalmente riconosciuta piena dignità e possibilità di esprimere un valore «altro» e indispensabile alla completezza del genere umano.
Una «soluzione» post o anti umana, per una questione radicalmente umana quale è il pregiudizio e la prevaricazione del più forte sul più debole, non può rappresentare una via da percorrere per chiunque abbia a cuore le sorti dell’umanità.
Anche oggi che quasi nessuno ha più il coraggio (e il buon senso) di esplicitare quei pensieri sulle donne (e molto spesso sono le donne stesse a sminuirsi e mortificarsi rispetto al maschio, in una sorta di «autofobia» indotta da secoli di indottrinamento), bisogna sapere che il pregiudizio misogino esiste e lavora nell’oscurità dell’animo di ognuno di noi.
Il lavorio profondo e costante che esso ha esercitato lungo i secoli, infatti, ha finito col costruire un retroterra di convinzioni e distinguo che è assai arduo mettere in discussione. Figuriamoci estirparlo.
4. La grande sfida del XXI secolo
Di fronte a questo orrore della mente umana emerge il valore fondamentale della filosofia. Sì, proprio quella disciplina che pur ha visto i suoi più autorevoli rappresentanti concettualizzare e perpetuare il pregiudizio misogino.
Grazie al pensiero critico (e autocritico) che la fonda e caratterizza, la filosofia può infatti assumersi la responsabilità per questo orrore concettuale contro la donna, ma anche approntare quegli strumenti logici, morali ed etici che permettano al genere umano di fare i conti con un pregiudizio tanto assurdo quanto indegno di ogni creatura pensante.
È il compito fondamentale che ci siamo assunti con questo libro. Da una parte ricostruire, finalmente e in maniera critica, la storia secolare di questo antico pregiudizio contro la donna (tirando in ballo le responsabilità della filosofia, ma anche della religione e delle scienze in genere), dall’altra proporre una nuova teoria della soggettività umana che possa agevolare il superamento di contrapposizioni e pregiudizi sessuali con i quali era pur ora di fare i conti.
Non si tratta soltanto di distruggere una miserevole e immotivata ingiustizia contro il genere femminile, con ricadute terribili e spesso drammatiche sul piano della vita concreta e quotidiana di tantissime donne, ma anche di riporre, e chiudere finalmente nel cassetto delle vergogne di cui è stato capace l’essere umano, una forma di pregiudizio ottuso che non rende onore a nessuno.
È inutile girarci intorno: il superamento del pregiudizio contro le donne rappresenta il compito fondamentale che si pone di fronte al genere umano nella nostra epoca.
Insieme all’individuazione di un nuovo modello di economia politica (che torni a ridurre le disuguaglianze sociali), nonché al ripensamento di uno sviluppo ecosostenibile (per le sorti di un pianeta allo stremo e con le risorse ridotte), l’eliminazione di un fardello che grava fin dalle origini su più della metà del genere umano si presenta a noi come la vera sfida del XXI secolo.
E dire che basterebbe davvero poco per comprendere l’assurdità che riveste il pregiudizio contro le donne fin dalle fondamenta.
Per esempio, come proviamo a spiegare alla fine del libro, potrebbe rappresentare un ottimo punto di partenza comprendere che «in alcun modo è stata divinamente approntata per noi la natura del mondo» (Lucrezio, De rerum natura: V, 198-9).
Liberarsi di questo egocentrismo prettamente umano, di questa clamorosa illusione di rappresentare il centro nonché il senso di tutte le cose, equivarrebbe in maniera immediata a rendersi conto della assurda pretesa di riuscire a decifrare i codici di un dio, della natura o del fato (per poi interpretarli secondo una nostra personale convinzione o un nostro specifico tornaconto).
Entità che avrebbero in qualche modo stabilito la scala gerarchica delle creature che abitano il nostro mondo.
Eppure, se anche esistesse un Dio, e se anche ciò che chiamiamo natura ci tenesse in così grande considerazione come ci intestardiamo a credere, alla fine dei conti dovremmo pur sempre ammettere che non possediamo le capacità di decifrare con sicurezza alcuna i criteri in base ai quali siamo stati gettati in questo mondo e in questa esistenza, figuriamoci stabilire la superiorità di alcuni esseri umani e l’inferiorità di altri.
Per di più in seguito a criteri del tutto non scientifici, traballanti, quanto mai soggettivi.
Un atteggiamento improntato al sano scetticismo e buon senso, piuttosto, potrebbe indurci alla consapevolezza che tutti, ma davvero tutti (donne, uomini, bianchi, neri, gay, lesbiche, ricchi, poveri etc.) condividiamo una condizione esistenziale di incertezza e tormento tali da suggerire ben più la comunione delle menti e delle forze, laddove possibile, che non il conflitto sterile e autodistruttivo.
Prima ancora di dividerci in uomini e donne, insomma, dovremmo riconoscerci tutti in quanto esseri umani (universali) e individui (irriducibili), e a fronte di ciò ritenere insensata e persino deleteria ogni forma di conflitto che esuli da piano concreto del sociale.
Da questo punto di vista, la vicenda secolare che ha colpito le donne sta lì a dimostrare che l’essere umano, almeno fino ad oggi, non è stato per nulla capace di giungere a una tale consapevolezza (o almeno a trarne le conseguenze).
Ecco perché fare i conti fino in fondo con il pregiudizio contro la donna, per provare finalmente a lasciarselo alle spalle, significa non soltanto liberare metà del genere umano da un fardello vergognoso e miserabile, ma permettere anche all’altra metà di acquisire una maggiore consapevolezza di cosa vuol dire abitare questo mondo e questa nostra umana esistenza.
Mestiere tutt’altro che agevole e rassicurante.
Grazie al pensiero critico (e autocritico) che la fonda e caratterizza, la filosofia può infatti assumersi la responsabilità per questo orrore concettuale contro la donna, ma anche approntare quegli strumenti logici, morali ed etici che permettano al genere umano di fare i conti con un pregiudizio tanto assurdo quanto indegno di ogni creatura pensante.
È il compito fondamentale che ci siamo assunti con questo libro. Da una parte ricostruire, finalmente e in maniera critica, la storia secolare di questo antico pregiudizio contro la donna (tirando in ballo le responsabilità della filosofia, ma anche della religione e delle scienze in genere), dall’altra proporre una nuova teoria della soggettività umana che possa agevolare il superamento di contrapposizioni e pregiudizi sessuali con i quali era pur ora di fare i conti.
Non si tratta soltanto di distruggere una miserevole e immotivata ingiustizia contro il genere femminile, con ricadute terribili e spesso drammatiche sul piano della vita concreta e quotidiana di tantissime donne, ma anche di riporre, e chiudere finalmente nel cassetto delle vergogne di cui è stato capace l’essere umano, una forma di pregiudizio ottuso che non rende onore a nessuno.
È inutile girarci intorno: il superamento del pregiudizio contro le donne rappresenta il compito fondamentale che si pone di fronte al genere umano nella nostra epoca.
Insieme all’individuazione di un nuovo modello di economia politica (che torni a ridurre le disuguaglianze sociali), nonché al ripensamento di uno sviluppo ecosostenibile (per le sorti di un pianeta allo stremo e con le risorse ridotte), l’eliminazione di un fardello che grava fin dalle origini su più della metà del genere umano si presenta a noi come la vera sfida del XXI secolo.
E dire che basterebbe davvero poco per comprendere l’assurdità che riveste il pregiudizio contro le donne fin dalle fondamenta.
Per esempio, come proviamo a spiegare alla fine del libro, potrebbe rappresentare un ottimo punto di partenza comprendere che «in alcun modo è stata divinamente approntata per noi la natura del mondo» (Lucrezio, De rerum natura: V, 198-9).
Liberarsi di questo egocentrismo prettamente umano, di questa clamorosa illusione di rappresentare il centro nonché il senso di tutte le cose, equivarrebbe in maniera immediata a rendersi conto della assurda pretesa di riuscire a decifrare i codici di un dio, della natura o del fato (per poi interpretarli secondo una nostra personale convinzione o un nostro specifico tornaconto).
Entità che avrebbero in qualche modo stabilito la scala gerarchica delle creature che abitano il nostro mondo.
Eppure, se anche esistesse un Dio, e se anche ciò che chiamiamo natura ci tenesse in così grande considerazione come ci intestardiamo a credere, alla fine dei conti dovremmo pur sempre ammettere che non possediamo le capacità di decifrare con sicurezza alcuna i criteri in base ai quali siamo stati gettati in questo mondo e in questa esistenza, figuriamoci stabilire la superiorità di alcuni esseri umani e l’inferiorità di altri.
Per di più in seguito a criteri del tutto non scientifici, traballanti, quanto mai soggettivi.
Un atteggiamento improntato al sano scetticismo e buon senso, piuttosto, potrebbe indurci alla consapevolezza che tutti, ma davvero tutti (donne, uomini, bianchi, neri, gay, lesbiche, ricchi, poveri etc.) condividiamo una condizione esistenziale di incertezza e tormento tali da suggerire ben più la comunione delle menti e delle forze, laddove possibile, che non il conflitto sterile e autodistruttivo.
Prima ancora di dividerci in uomini e donne, insomma, dovremmo riconoscerci tutti in quanto esseri umani (universali) e individui (irriducibili), e a fronte di ciò ritenere insensata e persino deleteria ogni forma di conflitto che esuli da piano concreto del sociale.
Da questo punto di vista, la vicenda secolare che ha colpito le donne sta lì a dimostrare che l’essere umano, almeno fino ad oggi, non è stato per nulla capace di giungere a una tale consapevolezza (o almeno a trarne le conseguenze).
Ecco perché fare i conti fino in fondo con il pregiudizio contro la donna, per provare finalmente a lasciarselo alle spalle, significa non soltanto liberare metà del genere umano da un fardello vergognoso e miserabile, ma permettere anche all’altra metà di acquisire una maggiore consapevolezza di cosa vuol dire abitare questo mondo e questa nostra umana esistenza.
Mestiere tutt’altro che agevole e rassicurante.
Da: Contro le donne. Storia e critica del più antico pregiudizio di Paolo Ercolani, Marsilio, 2016
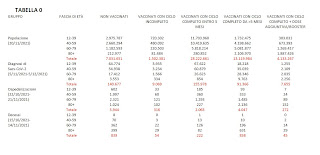




Commenti
Posta un commento